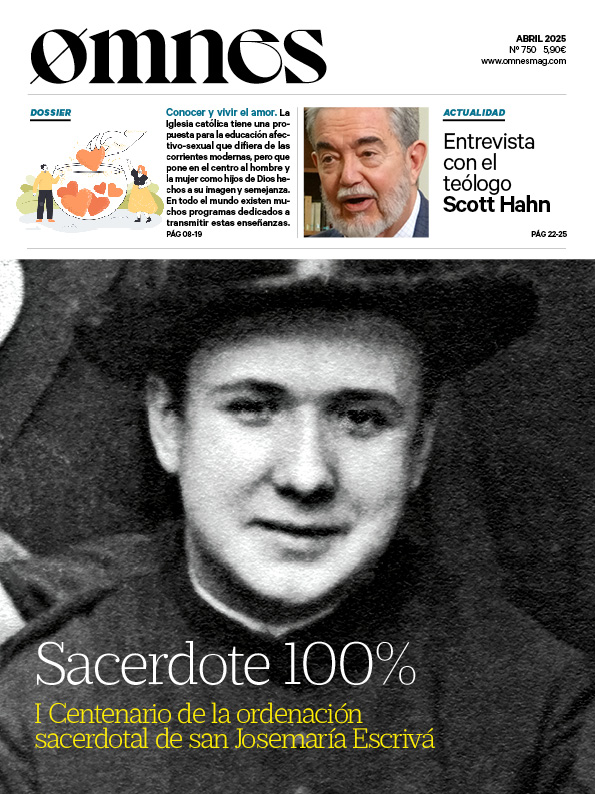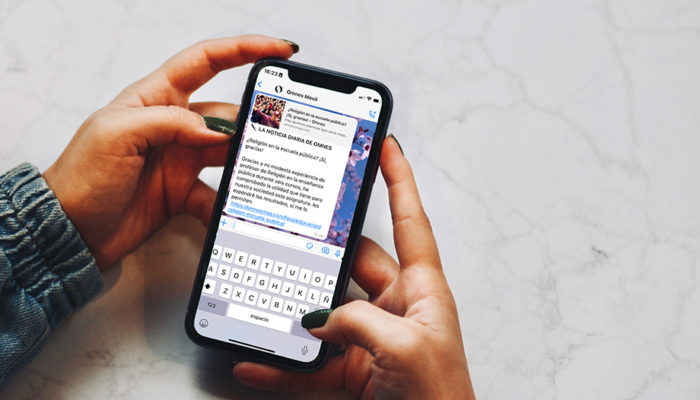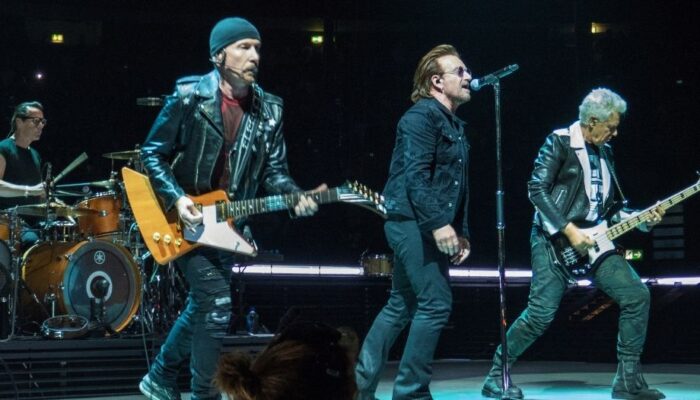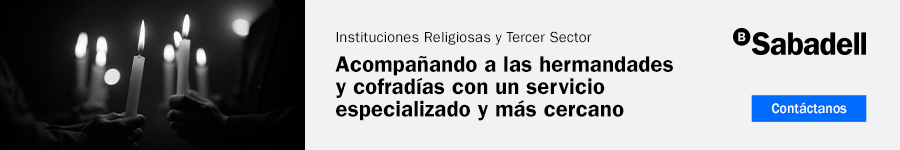I demonidi F.M. Dostoevskij. Un viaggio nella "solidarietà" morale
I demonidi F.M. Dostoevskij. Un viaggio nella "solidarietà" morale Barefoot", il film di Hakuna sulla forza vitale della musica
Barefoot", il film di Hakuna sulla forza vitale della musica "Nessun dialogo con il diavolo" ricorda il Papa all'Angelus
"Nessun dialogo con il diavolo" ricorda il Papa all'AngelusIl film Nefarius (2023), diretto dai registi americani Chuck Konzelman e Cary Solomon, presenta con notevole realismo un'intensa conversazione tra un condannato a morte posseduto da un demone crudele e intelligente e lo psichiatra incaricato di valutarlo in carcere. La tensione narrativa si basa quasi esclusivamente sul dialogo tra i due personaggi, ottenendo un'atmosfera inquietante e profondamente riflessiva.
Il film è concepito da un punto di vista ecumenico, cioè evita esplicitamente qualsiasi riferimento particolare al cattolicesimo, come l'intercessione della Vergine Maria, i santi, i sacramenti o il sacerdozio ministeriale. Tuttavia, il nucleo del messaggio è profondamente spirituale e ruota attorno alla fiducia assoluta in Dio, la cui azione salvifica è centrale. Ciò è indicato dall'insegnamento stesso di Gesù Cristo nel Padre Nostro: "Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male" (Mt 6,13).
La durezza della storia, a volte difficile da sopportare, sembra anche finalizzata a generare una seria riflessione sull'abolizione della pena di morte. In questo senso, il film può essere letto come un appello a favore della vita, in linea con la modifica del Catechismo della Chiesa Cattolica promossa da Papa Francesco.
Un dibattito moderno sul male
La caratterizzazione dei personaggi e il ritmo delle sequenze catturano immediatamente l'attenzione dello spettatore, che si trova immerso in un vero e proprio dibattito sul bene e sul male nel mondo contemporaneo. Il film smaschera gli argomenti della post-modernità e mette lo spettatore di fronte a una realtà spirituale spesso ignorata o ridicolizzata.
In questo quadro, emerge un grande paradosso: il demone Nefarius lavora fin dall'infanzia dello psichiatra per influenzare la sua anima, seminando l'ateismo e preparando il terreno affinché, al momento opportuno, firmi una condanna a morte. La conversazione tra i due mostra come la negazione dello spirituale (l'esistenza di Dio, del diavolo, dell'anima) possa nascondere il vero dramma interiore dell'essere umano.
Konzelman e Solomon riescono a trasmettere, con notevole abilità, come lo psichiatra riesca a salvarsi dalla possessione riacquistando la fede e affidandosi nuovamente a Dio. È proprio questa invocazione che impedisce al demone di entrare in lui. Così, il percorso del male appare come un processo: inizia con l'orgoglio e l'egoismo, passa attraverso la sfiducia in Dio e culmina nella sua negazione o nell'adorazione di una falsa immagine, deformata da Satana stesso.
Il film sottolinea, in modo chiaro e profondo, che il rifiuto di Dio porta a una radicale incapacità di affrontare il problema del male, sia nella propria sofferenza che in quella degli altri. E quando si nega Dio, il male diventa ancora più incomprensibile e senza speranza. L'obiettivo non è quello di risolvere il problema del male, ma di metterlo in luce. Per una riflessione più ampia su questa questione, si veda il recente lavoro di José Antonio Ibáñez Langlois.
Il mistero della sofferenza e la libertà umana
È importante distinguere tra due tipi di male: il male fisico e il male morale. Per quanto riguarda il primo, è sufficiente ricordare che la creazione è un sistema naturale in equilibrio, dove alcuni processi comportano dolore o distruzione, ma non sono privi di significato. Dio non è l'autore del male, né direttamente né indirettamente. Egli ha creato il mondo con le sue leggi naturali ed è sempre presente per aiutarci a dare un senso trascendente ai nostri disturbi.
Per quanto riguarda il male morale - il peccato - Dio lo permette perché ha voluto soprattutto che gli esseri umani fossero liberi, capaci di scegliere il bene e quindi di amare. Libertà che, come ricordava San Giovanni Paolo II in Veritatis splendorè inseparabilmente legata alla Verità, che è Cristo stesso: "Via, Verità e Vita". Per questo San Tommaso intende la libertà come forza, San Josemaría come energia e Edith Stein come coraggio dell'anima libera.
Una risposta cristiana alla sofferenza
Infine, vale la pena sottolineare la lucida esposizione della sofferenza offerta da San Giovanni Paolo II in Salvifici doloris. Di fronte alla grande domanda sorta dopo l'orrore dell'Olocausto: "Perché Dio ha permesso questo? Benedetto XVI Ha proposto di trasformare la riflessione in preghiera: "Perché, Signore, hai permesso questo? E Giovanni Paolo II ha dato una risposta cristiana e piena di speranza: la sofferenza può diventare una vocazione, una partecipazione alla croce redentrice di Cristo. Un mistero che non elimina il dolore, ma gli dà un significato eterno.
Vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Santo Domingo, Repubblica Dominicana