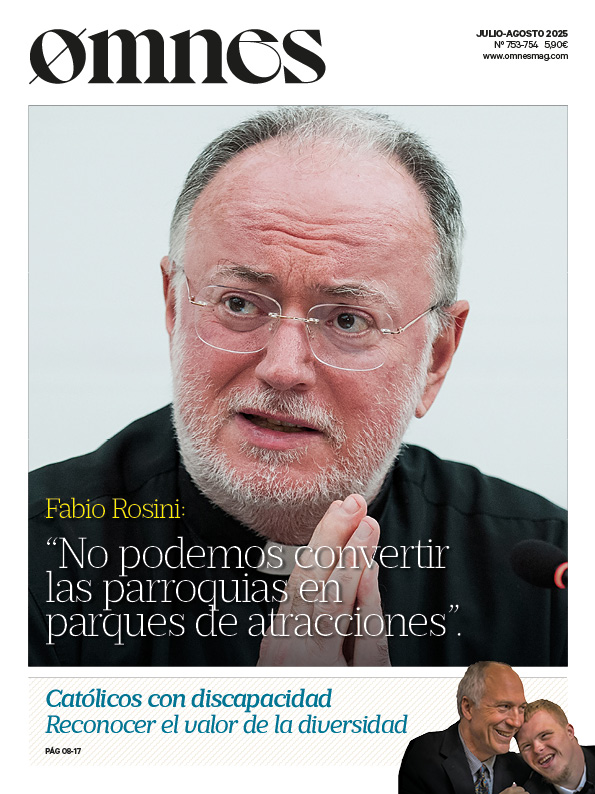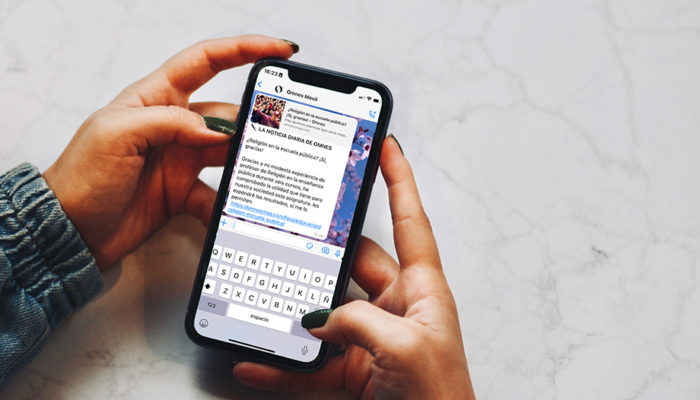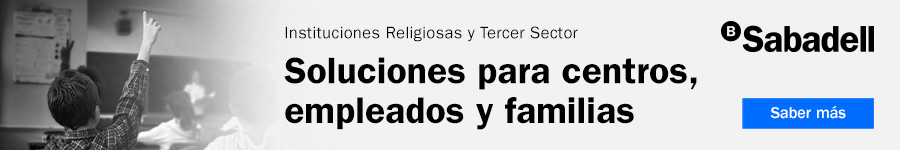Il famoso filosofo prussiano Immanuel Kant (1724-1804) ha lasciato una testimonianza personale di una persona onesta e laboriosa. Era più simpatico e sociale di quanto un'aneddotica poco accurata lo abbia talvolta dipinto. Di origine umile e protestante, con un impegno intellettuale e una serietà morale a cui non rinunciò mai, anche se perse la fede nella rivelazione cristiana e forse in Dio. Alcuni frammenti della sua Opus postumum (ed. 1882, 1938) può dare questa sensazione, difficile da valutare.
L'illuminazione di Kant
È il più rappresentativo e, allo stesso tempo, il meno illuminato, perché gli altri non sono né così profondi né così seri. E non era un massone. Inoltre, ci sono molti ilustrados cattolici (Maya, Feijóo, Jovellanos...). Ma lui ha definito Che cos'è l'illustrazione (1784), riassumendolo nel motto "Osare conoscere". (sapere aude). Ciò significava diventare intellettualmente adulti e liberarsi dai tutori e dalle tutele (e anche dalla censura statale prussiana e protestante) per pensare con la propria testa e cercare la conoscenza da tutte le fonti autentiche. Un ideale che i cattolici potevano e hanno abbracciato in tutte le conoscenze naturali. Siamo tuttavia consapevoli che abbiamo bisogno della rivelazione di Dio per conoscere le profondità del mondo creato e di noi stessi, e anche per salvarci in Cristo.
Ma Kant, come molti del suo tempo e del nostro, non si fidava delle testimonianze storiche cristiane. Voleva quindi staccare la religione cristiana dalla sua base storica (Gesù Cristo) e così compose La religione nei limiti della ragione (1792). Riducendo il cristianesimo a una morale senza dogmi e avendo ampie ripercussioni nel mondo protestante (Schleiermacher) e cattolico (modernismo).
Si dice che, così come il pensiero cattolico dipende da Aristotele cristianizzato da San Tommaso, il pensiero protestante dipende da Kant cristianizzato da Schleiermacher (1768-1834). La differenza è che San Tommaso Il vocabolario di Aristotele lo aiuta a pensare e formulare bene la Trinità e l'Incarnazione, mentre per Schleiermacher l'agnosticismo di Kant lo costringe a trasformare i misteri cristiani in brillanti metafore. Rimane solo la coscienza umana di fronte all'assoluto e Cristo come realizzazione ultima (almeno per il momento) di questa posizione. E il comandamento dell'amore verso il prossimo come aspirazione alla fratellanza universale, che è ciò che il liberalismo protestante che segue Schleiermacher riassumerà come segue L'essenza del cristianesimo (1901, Harnack).
Ma il cattolico Guardini gli ricorderà che L'essenza del cristianesimo (ed. 1923, 1928) è una persona e non un'idea, Gesù Cristo. Che questo Gesù Cristo sia Il Signore (1937), il Figlio di Dio, al quale siamo uniti dallo Spirito Santo. E che tutto questo è celebrato, vissuto ed espresso nella liturgia sacramentale della Chiesa (Lo spirito della liturgia, 1918).
La Critica della ragion pura
Nel background filosofico di Kant si scontrano due tradizioni: da un lato, quella razionalista di Spinoza e Leibnitz, ma soprattutto quella di Christian Wolff (1679-1754), oggi quasi sconosciuto, ma autore di un'opera filosofica enciclopedica con tutte le specialità e la metafisica, incentrata su Dio, il mondo e l'anima. Kant non conosceva direttamente né la tradizione scolastica medievale né quella greca classica (non leggeva il greco). Pertanto, la sua Critica della ragion pura (ed. 1781, 1787)Soprattutto, è critico nei confronti del metodo razionalista di Wolff e della sua metafisica.
Ciò si scontra con l'empirismo inglese, in particolare con quello di Hume (1711-1776), con la sua radicale distinzione tra l'esperienza dei sensi (empirica) e la logica delle nozioni, che danno origine a due tipi di prove (Mater di fatto / Relazione di idee). E la sua critica a nozioni chiave come quella di "sostanza (nozione di soggetto ontologico), che comprende l'io e l'anima, e quella di soggetto ontologico. "causalità. Per Hume, un insieme di esperienze dell'io unite dalla memoria non può essere convertito in un soggetto (un'anima) e nemmeno una successione empirica e abituale può essere convertita in un vero e proprio "causalità razionale". dove l'idea di una cosa ne costringe logicamente un'altra. A questo si aggiunge la fisica di Newton, che scopre un comportamento necessario nell'universo con leggi matematiche. Ma come può esistere un comportamento "necessario" in un mondo empirico?
Kant dedurrà che le forme e le idee che la realtà non può dare, perché è empirica, sono detenute e date dalle nostre facoltà: la sensibilità (che dà spazio e tempo), l'intelligenza (che detiene e dà la causalità e le altre categorie kantiane) e la ragione (pura), che gestisce le idee di anima (sé), mondo e Dio, come un modo per unire coerentemente tutta l'esperienza interna (anima), esterna (mondo) e la relazione tra le due (Dio). Ciò significa (e questo è ciò che dice Kant) che l'esperienza esterna mette in relazione l'anima con il mondo. "materia" di conoscenza, e le nostre facoltà le danno "forma".. Così, ciò che è intelligente è stabilito dal nostro spirito e non è possibile discernere ciò che sta al di là di esso. Kant non lo riconosce, ma l'idealismo successivo lo porterà all'estremo (Fichte e Hegel).
Reazioni cattoliche
Il Critica della ragion pura suscitò subito una forte reazione negli ambienti cattolici, soprattutto tra i tomisti. Spesso intelligente, a volte inelegante. Probabilmente è stato l'ambiente che gli ha dedicato maggiore attenzione, consapevole della posta in gioco. Sebbene il riferimento immediato di Kant sia la metafisica di Wolff (e questo produce alcune distorsioni), tutta la metafisica classica (e la teoria della conoscenza) ne è interessata. Questo sforzo ha dato origine persino a una materia nel curriculum, chiamata, a seconda dei casi, Epistemologia, Critica della conoscenza o Teoria della conoscenza.
La tradizione tomistica, con tutto il suo arsenale logico scolastico, disponeva di strumenti di analisi più raffinati di quelli utilizzati da Kant, sebbene anche le analisi kantiane li abbiano talvolta sopraffatti. Con una certa ignorantia elenchiKant ripropone l'immensamente dibattuto problema scolastico degli universali. Ovvero, come è possibile ricavare nozioni universali dall'esperienza concreta della realtà. Ciò richiede una buona comprensione dell'astrazione e della separazione, nonché dell'induzione, operazioni di conoscenza molto studiate dalla scolastica. Inoltre, la "entità della ragione". (come lo spazio e il tempo) che hanno una base reale e possono essere separati mentalmente dalla realtà, ma non sono cose, né sono forme di conoscenza precedenti.
Il gesuita Benedict Stattler ha pubblicato un Anti-Kantin due volumi, già nel 1788. Da allora ne sono stati pubblicati molti altri. Vale la pena di notare l'attenzione che gli ha dedicato Jaime Balmes nel suo Filosofia fondamentale (1849), e Maurice Blondel nel suo Note su Kant (in L'illusione idealistica1898), e Roger Vernaux, nel suo commento alle tre critiche (1982) e in altre opere (come il suo vocabolario kantiano). Anche gli autori cattolici delle grandi storie della filosofia, che gli dedicano importanti e serene critiche. Teófilo Urdánoz, per esempio, dedica 55 pagine del suo Storia della filosofia (IV) al Critica della ragion purae Copleston quasi 100 (VI). Naturalmente, Kant ha fatto riflettere molto il mondo cattolico.
La Critica della Ragion Pratica
Così come il Critica della ragion pura finisce in un certo (anche se forse produttivo) scioglilingua e in un circolo vizioso (perché non c'è modo di sapere ciò che possiamo sapere), il Critica della ragion pratica (1788)è un interessante esperimento su ciò che la ragione pura può stabilire autonomamente nella morale. Certo, va detto subito che la morale non può essere dedotta interamente dalla ragione, perché in parte è ricavata dall'esperienza (per esempio, la morale sessuale o economica) e ci sono anche intuizioni che ci fanno percepire che qualcosa funziona o non funziona, o che c'è un dovere di umanità o che stiamo per fare del male. Ma Kant tende a non tenere conto di ciò che sembra essere "sentimentalismo".perché si propone di essere del tutto razionale e autonomo nella scoperta delle regole universali dell'azione. Questo è il suo pregio e, allo stesso tempo, il suo limite.
Come primo imperativo categorico (autoevidente e autoimposto), affermerà: "Agite in modo tale che la massima della vostra volontà possa essere sempre valida allo stesso tempo del principio di una legislazione universale".. Un principio valido e interessante in astratto, anche se nella sua attuazione pratica nella coscienza richiede una portata e uno sforzo in molti casi impossibili: come dedurne tutti i comportamenti quotidiani. Un secondo principio, che compare nella La logica del Metafisica della morale (1785), è: "L'uomo, e in generale ogni essere razionale, esiste come fine in sé, non solo come mezzo per qualsiasi uso di questa o quella volontà; egli deve in tutte le sue azioni, non solo quelle dirette a se stesso, ma anche quelle dirette ad altri esseri razionali, essere sempre considerato allo stesso tempo come un fine". (A 65).
Solo per questa felice formulazione Kant meriterebbe un posto di rilievo nella storia dell'etica. Giovanni Paolo II, nel riflettere sui fondamenti della morale sessuale, si è basato molto su questa massima per distinguere ciò che può essere un uso irrispettoso di un'altra persona o, in termini positivi, che la vita sessuale è sempre un trattamento dignitoso, giusto e bello tra persone (Amore e responsabilità, 1960). E ha dato origine a ciò che l'allora professore di morale, Karol Wojtyla, chiamava "regola personalista".. Alla considerazione kantiana, ha aggiunto che la vera dignità dell'essere umano come figlio di Dio richiede non solo il rispetto, ma anche il comandamento dell'amore. Ogni persona, per la sua dignità personale, merita di essere amata.
C'è un altro aspetto che colpisce nel tentativo kantiano di una morale razionale e autonoma. Si tratta del "tre postulati della ragion pratica. Per Kant sono principi necessari al funzionamento della morale, ma indimostrabili: l'esistenza della libertà, l'immortalità dell'anima e Dio stesso. Se non c'è libertà, non c'è moralità. Se non c'è Dio, non è possibile armonizzare felicità e virtù e garantire il successo della giustizia con la giusta punizione. Questo richiede anche l'immortalità dell'anima aperta a una perfezione che qui è impossibile. Questo richiama il commento di Benedetto XVI sui fondamenti della vita politica, che devono essere etsi Deus daretur, come se Dio esistesse. Anche la morale razionale può funzionare solo etsi Deus daretur.
Infine, colpisce il fatto che Kant si riferisca in diversi punti alla "male radicale".. L'evidenza, così contraria alla razionalità adulta e autonoma, che gli esseri umani, con sorprendente frequenza e con piena lucidità, non fanno ciò che sanno di dover fare o fanno ciò che sanno di non dover fare: l'esperienza di San Paolo in Romani 7 ("Non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio".Come capirlo? E, soprattutto, come risolverlo?
Il tomismo trascendentale di Marechal (e Rahner)
Il gesuita Joseph Marechal (1878-1944) è stato professore presso la casa dei gesuiti di Lovanio (1919-1935). Ha dedicato molta attenzione a Kant, che si riflette nei cinque volumi della sua opera Il punto di partenza della metafisica (1922-1947) pubblicati da Gredos in un unico volume e tradotti tra gli altri da A. Millán Puelles. In particolare nel volume IV (ed. francese), Maréchal ha prestato attenzione al tema kantiano delle condizioni a priori o condizioni di possibilità della conoscenza.
Karl Rahner (1904-1984), sempre attento agli ultimi sviluppi intellettuali, prese in prestito alcune nozioni e vocaboli dal tomismo trascendentale di Maréchal. Soprattutto, il "condizioni di possibilità. La sua teologia fondamentale si basa su questo, perché pensa che la comprensione umana sia creata con condizioni di possibilità che la rendono capace di rivelazione e, in questa misura, sono una sorta di rivelazione. "atematico". già implicito nella comprensione stessa. Ed è ciò che rende tutti gli uomini in qualche modo "Cristiani anonimi. La critica da fare è che la comprensione stessa, così com'è, è già in grado di conoscere la rivelazione che le è stata data in modo adeguato al modo umano di comprendere, "con fatti e parole". (Dei verbum). Tutti gli esseri umani sono "Cristiani anonimiMa non perché lo sono già, bensì perché sono chiamati ad esserlo.
Per molti versi, quindi, Kant ha fatto riflettere e lavorare molto i filosofi e i teologi cattolici, anche se è difficile fare una valutazione generale dei risultati a causa dell'immensa ampiezza e complessità delle questioni.